Gianni Oliva
Sui libri di storia decidono i docenti
La Stampa, 30 luglio 2025
Sono invidiosissimo dei colleghi che hanno scritto il manuale di storia della Laterza: una polemica nazionale è un’iniezione di pubblicità senza paragoni, insieme insperata, radicale e gratuita.
Non so quali fossero le intenzioni dell’onorevole Montaruli, che l’ha sollevata per prima: certo è che le battaglie identitarie servono a compattare la “curva sud” del proprio elettorato ma hanno, come inevitabile effetto, quello di scatenare una presa di posizione identitaria di segno opposto.
E così il manuale scolastico incriminato sta uscendo dal “gruppo” dei manuali in adozione e rapidamente sta diventando un testo da esaminare con più attenzione: non è più “il manuale della Laterza”, ma “il manuale che la Destra non vuole”. Come risultato, mi sembra discutibile e mortificante per tutti, detrattori e incensatori.
La Storia, si sa, è terreno insidioso perché per sua natura non è oggettiva, non approda a verità incontrovertibili come le scienze esatte. «La storia nasce dalle domande che il presente pone al passato» scriveva Marc Bloch: cambia il presente, cambiano le domande, cambiano gli indirizzi di ricerca e, in parte, cambiano le interpretazioni. Per questo Benedetto Croce sosteneva, a sua volta, che «la storia è sempre storia contemporanea»: anche se si studiano gli antichi Fenici o gli antichi Romani lo facciamo sempre dal punto di vista del presente.
Il dovere della storia è quello di essere “obiettiva”, cioè di partire dai documenti per arrivare ad una interpretazione, e non da un’interpretazione per trovare i documenti che la confermino. Mi sono laureato con un grande intellettuale torinese, Alessandro Galante Garrone, che un giorno mi sintetizzò il messaggio metodologico con una semplicità tanto incisiva quanto disarmante: «Quando scrivi un saggio di storia, nessuno di coloro che lo leggono devono capire per chi voti». Deve essere così per i saggi, deve essere così per i manuali.
Ma se di fronte ad un saggio il giudizio sull’obiettività (e quindi sulla validità) spetta al lettore che lo acquista, di fronte ad un manuale scolastico chi stabilisce se il testo ha o meno i requisiti adatti? Nell’Italia liberale operava nel ministero dell’Istruzione un’apposita Commissione sui libri di testo, deputata all’approvazione preventiva. Nel 1923 Giovanni Gentile ha ripristinato lo strumento, indirizzandolo prevalentemente al controllo dei testi destinati alle scuole elementari e alla formazione professionale; dopo il 1928 il problema è stato superato con l’introduzione del libro unico di Stato.
Ma nella scuola repubblicana il compito di stabilire l’idoneità è stata trasferita ai docenti e, con i decreti delegati del 1974, ai Consigli di classe e ai Collegi Docenti, chiamati in primavera ad approvare le adozioni per l’anno scolastico successivo. Ciò significa che il processo decisionale è stato trasferito a coloro che utilizzano i testi, ed è stato trasferito in una dimensione collegiale, dove ognuno spiega le proprie ragioni e, al momento del voto, ognuno conta per uno.
Qual è il proposito, ora? Tornare alle Commissioni che danno il parere preventivo? Alla supervisione ideologica del Ministero? E quante pagine (o quante righe) devono essere incriminate perché un manuale venga respinto?
Se posso permettermi, un consiglio ai decisori politici. Lascino che siano i docenti a giudicare e a scegliere e si preoccupino, invece, di un’altra cosa: e cioè che a pag. 666 del manuale, non arriverà mai nessuna classe. Perché nella nostra scuola la storia è poco in onore e, soprattutto, non è in onore la storia contemporanea. Questo è il vero problema, il vero vulnus: avere studenti che qualcosa di Annibale hanno orecchiato, ma non hanno quasi mai sentito parlare di Piazza Fontana e di Aldo Moro. Altro che gli equivoci sul sovranismo, sulle politiche sull’emigrazione, o sulle radici ideologiche di FdI. La politica rifletta su questo e intervenga, anziché fare battaglie identitarie sulla pag. 666…!


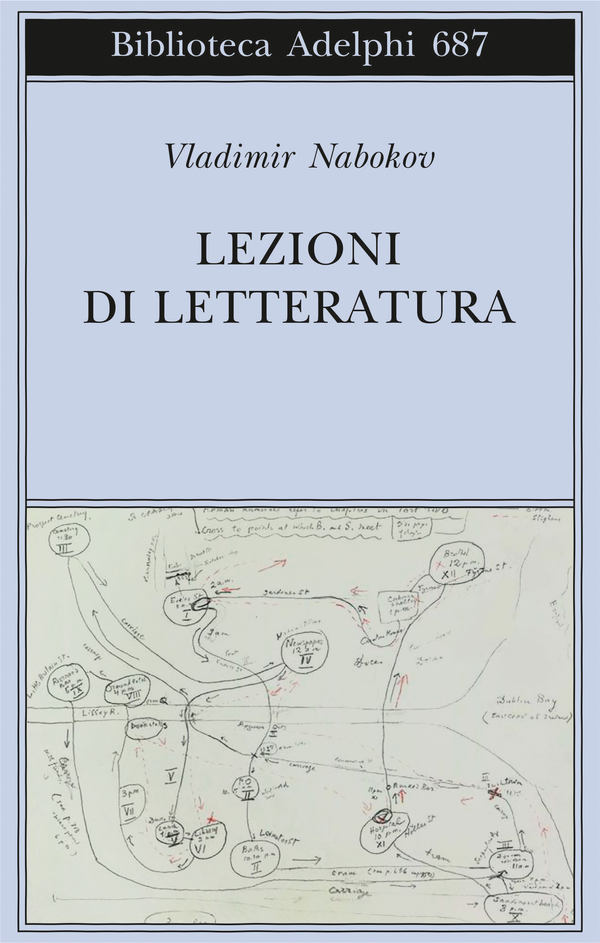




.jpg)
