Massimo Gaggi, Consenso e passi falsi, Corriere della Sera, 3 aprile 2025
Donald Trump, eletto dalla parte dell’America che credeva nel suo tocco magico in economia («una nuova età dell’oro») come in politica estera (la promessa di mettere fine alla guerra in Ucraina in 24 ore, di portare la pace in Medio Oriente, di imporre all’Iran un nuovo accordo sul nucleare), sembrava in grado di coagulare vasti consensi nonostante una logica autoritaria all’interno e imperiale nel mondo. Anche grazie a Elon Musk che aveva messo il turbo alla sua presidenza.
Sembrano storie remote ma sono passati solo tre mesi: Natale di grande ottimismo, mercati ai massimi. E attese messianiche per il 20 gennaio, giorno del suo insediamento. Trump, consapevole di aver esagerato, archiviò la retorica delle 24 ore, ma dava comunque per certi un accordo con Putin entro settimane e il rafforzarsi della tregua Israele-hamas negoziata dai diplomatici di Biden, ma col suo sostegno. E invece oggi Trump è furioso con l’«amico» Putin mentre i suoi ammettono che per fermare la guerra ci vorranno mesi. A Gaza, Israele allarga di nuovo il conflitto e l’iran rifiuta il negoziato diretto con Washington. Intanto, coi nuovi dazi, il «giorno della liberazione» rischia di diventare quello dell’incubo, mentre la stella di Musk ha smesso di brillare nel firmamento trumpiano. Impressionante vedere quanti passi falsi Trump ha fatto in poche settimane in giro per il mondo: la scena di Zelensky schiaffeggiato e umiliato alla Casa Bianca è stata, in realtà, soprattutto un autogol: ha reso Putin baldanzoso mentre il tentativo del presidente di dare le colpe del mancato accordo a Kiev è fallito visto che, sia pure obtorto collo, il leader ucraino ha finito per accettare tanto le concessioni territoriali alla Russia quanto un accordo sulle risorse minerarie del Paese enormemente favorevole per gli Stati Uniti. Quanto all’iran, Trump, che non è stato mai chiamato a rispondere dell’errore di aver cancellato, nel suo primo mandato, l’accordo nucleare negoziato da Barack Obama (inadeguato secondo Netanyahu, ma sempre meglio del vuoto che è seguito), ora minaccia Teheran ma propone anche una nuova trattativa, convinto che gli ayatollah, ormai alle corde in tutte le loro aree di influenza, dalla Siria al Mar Rosso passando per Hezbollah e Hamas, non potranno tirarsi indietro. E invece Teheran rifiuta il negoziato diretto con la Casa Bianca che ora pare costretta ad accettare un percorso più impervio: un dialogo indiretto attraverso la mediazione dell’Oman.
Quanto a Israele, la strategia di Trump che continua a puntare, e con fondamento, a rilanciare il dialogo dello Stato ebraico con l’Arabia Saudita per stabilizzare l’area isolando sempre più l’islam sciita dell’Iran, rischia di essere compromessa dalla recrudescenza del conflitto con nuove stragi, il ritorno dell’esercito israeliano a Gaza, i piani per un’emigrazione forzata dei palestinesi, inaccettabili anche per i Paesi sunniti che avevano preso a dialogare con Israele.
Certo, con l’eccezione dei palestinesi e dello Stato ebraico, la politica estera incide relativamente poco sugli umori degli americani. E nelle sue prime dieci settimane di governo Trump ha puntato molto anche su temi per i quali il suo elettorato ha mostrato maggiore sensibilità: soprattutto l’immigrazione clandestina, ma anche le culture wars attaccando quella woke della sinistra radicale. Accuse e misure spesso a dir poco controverse — dall’abolizione, probabilmente illegale, dei programmi Dei (tutela di diversità, equità e inclusione) al ripristino delle statue e delle targhe che celebrano i secessionisti che nella Guerra civile di metà Ottocento si battevano per il mantenimento della schiavitù.
Ma quelli che dovevano essere i due cardini della sua azione economica — da un lato i dazi per punire i Paesi che esportano massicciamente negli Stati Uniti, riportando al tempo stesso in patria le produzioni trasferite da industrie americane in Paesi dove il costo del lavoro è più basso, dall’altro la rivoluzione amministrativa di Musk — stanno avendo effetti disastrosi. Testimoniati sul piano finanziario dalla più grave flessione delle Borse degli ultimi anni, su quello economico dal rischio di una ripresa dell’inflazione e dalla possibilità di una recessione (certa entro la fine dell’anno secondo il capo economista dell’agenzia di rating Moody’s, Mark Zandi, se la politica Usa dei dazi continuerà fino a settembre) e su quello politico dal primo piccolo ma significativo test elettorale di martedì scorso, il primo dalle presidenziali: la sconfitta in Wisconsin nell’elezione di un giudice della Corte suprema è ancor più bruciante perché Musk, considerato un grande trascinatore anche in chiave elettorale, si era gettato anima e corpo nella mischia, in questo Stato conquistato il 5 novembre da Trump.
Così l’immagine di Musk rischia di mutare: da apripista a zavorra. È presto per tirare conclusioni. Trump non può liberarsi di Elon come fece otto anni fa con Thiel, un altro big della Silicon Valley sbarcato alla Casa Bianca. Stavolta gli imprenditori digitali sono entrati nell’amministrazione con molti uomini e con piani ambiziosi: trasformazioni che il presidente apprezza e che, se funzioneranno, possono diventare la sua eredità storica. Ma Donald è anche un leader brutale con un’allergia istintiva, animalesca, per i loser. Lo stesso Musk potrebbe sfilarsi prima di cadere nella trappola.
Intanto un altro loser, Joe Biden, si gode lo spettacolo: la sua presidenza è finita male ma l’inizio — tra ripresa post Covid, accordi bipartisan per il piano infrastrutture e il rilancio tecnologico dell’America — era stato bruciante: una «luna di miele» durata sei mesi. Quella di Trump sembra già ai titoli di coda.
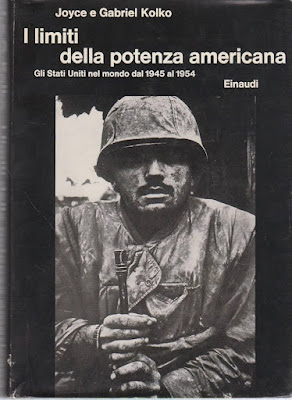
Nessun commento:
Posta un commento