Fabio Bordignon, Pd: se stare "fuori" non basta, Il mattino di Padova, 1 aprile 2018
C’è un dato che colpisce, in queste prime, convulse settimane della nuova legislatura: la totale assenza del Partito democratico. Colpisce perché a ritrovarsi improvvisamente ai margini – anzi, tagliato fuori dalla frenetiche trattative tra leader e compagini parlamentari - è quello che è stato un attore centrale, per alcune fasi addirittura l’unico attore rilevante sulla scena politica, onnipresente con i suoi uomini e il suo capo.
All’inizio era la logica della responsabilità: la responsabilità del primo partito di opposizione, durante la crisi del 2011. Poi, all’indomani delle Politiche 2013, la responsabilità di chi era arrivato primo, senza vincere. Così, all’interno di una coalizione sempre meno “grande”, il Pd è diventato, a tutti gli effetti, il partito di governo. Di più: il partito delle istituzioni, il partito del sistema. Questo cambio di immagine è ancora più esplicito se si considera la traiettoria complessiva del renzismo. Il leader fiorentino è colui che arriva da Fuori! – con il punto esclamativo, nella copertina del libro pubblicato nel 2011. È l’insurgent che indica la porta alle vecchie oligarchie: il Fuori! del rottamatore equivale al tutti a casa grillino. In questo senso, Renzi è in perfetta sintonia con lo spirito del tempo: persino le sue mosse più spregiudicate e “cattive” sono premiate dall’elettorato. Tuttavia, proprio l’ingresso nel palazzo è il peccato originale che segna il percorso successivo. Nel quale la spinta al rinnovamento e l’apertura alla società si trasformano in progressivo arroccamento nelle stanze del potere. Diventano, agli occhi di molti elettori, bulimia di potere, volontà di occupare ogni spazio di visibilità e influenza.
Il risultato del 4 marzo fotografa, nella sua composizione territoriale, sociale, degli orientamenti, questa metamorfosi. Il Pd è un partito lontano dalle periferie - geografiche e sociali - incapace di intercettare un malessere che non ha solo un volto di tipo economico, ma anche radici di matrice culturale: si pensi alle paure legate all’immigrazione. Più in generale, è il partito di coloro che hanno maggiore fiducia nei confronti delle istituzioni, nazionali ed europee. In sintesi, rappresenta tutto ciò che va contro lo spirito del tempo.
Alla luce di questo percorso, appare persino scontato che il Pd, in questa fase, scelga di tenersi lontano - il più possibile - dal gran ballo delle alleanze parlamentari. Provi a resistere alla tentazione di partecipare alla spartizione di posizioni e incarichi. Respinga gli appelli alla responsabilità. E decida di rimanere, dopo tanto tempo, veramente fuori: da tutto. Rischia così l’irrilevanza? Sicuramente sì. Ma potrebbe essere l’unica chance di sopravvivenza.
Stare fuori, aspettando gli errori degli avversari, però, non basta. Per provare a ripartire, serve una nuova visione: una “idea” di Paese. E serve una leadership. Le due cose vanno insieme, e insieme sembrano del tutto assenti. La vecchia leadership, all’opposto, sembra fare da “tappo” rispetto a qualsiasi ipotesi di rilancio. Difficile dire se e quale ruolo avranno, in futuro, il renzismo e i renziani: i veri sconfitti del #4marzo. Difficile però, al contempo, prevedere se l’opposizione interna riuscirà a prendere in mano un partito che, ad oggi, rimane ampiamente personalizzato (per non dire militarizzato).
Entrambe le parti, tuttavia, hanno un interesse comune: ripartire dal Pd. O meglio, da quel che rimane della forma-partito immaginata nel 2007. E che ne ha garantito le (alterne) fortune, in alcune brevi stagioni. Ripartire dalla base, ristretta ma comunque ampia. Una comunità che in passato ha sempre risposto all’appello, quando è stata coinvolta. Ecco allora la parola d’ordine: ri-attivare e in parte ripensare i meccanismi di coinvolgimento, continuo, e di confronto, aperto. Tornare a frequentare i luoghi di vita delle persone: sul territorio e in rete. Ma senza rete di protezione: per nessuno. Ripartire dal basso, prima di sprofondare.


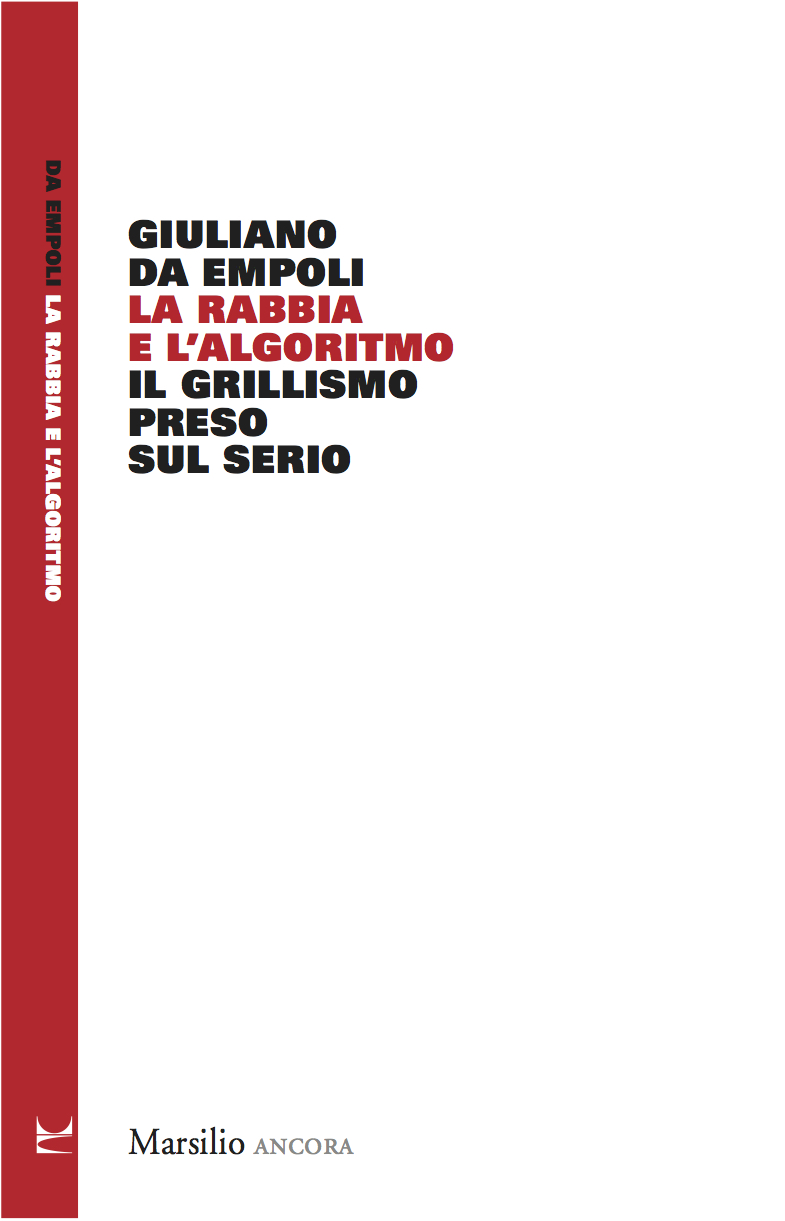 Finora,
ci sono stati tre tentativi di risposta al grillismo. “La tentazione
giacobina”; “la tentazione elitaria”; “la tentazione dorotea”. La prima
consiste nell’inseguire i grillini sul loro terreno, diventando più
populisti, più antipolitici e più giacobini di loro, adottando un frame
che quindi darà solo vantaggi agli inseguiti e non agli inseguitori. La
seconda consiste nell’attribuire il successo del M5s all’ignoranza e
alla manipolazione, come se il Movimento prendesse milioni di voti per
qualche centinaio di troll su Twitter e Facebook. La terza consiste
“nell’asserragliarsi nel bunker del sistema, in un grande revival
nostalgico della Prima Repubblica”. Le tre tentazioni, portate alle
estreme conseguenze, dice da Empoli, sono destinate a fallire. Così come
è destinata a fallire la sola opera di denuncia costante delle
contraddizioni, degli abusi e delle violazioni dei principi democratici
del M5s. All’origine del successo del populismo grillino c’è una
formidabile capacità di attrazione della rabbia che un tempo, come ha
rilevato il filosofo Peter Sloterdijk, era propria dei partiti di
sinistra, che “sono stati per tutto il Novecento i collettori
privilegiati della rabbia popolare”. Recentemente, il Pd aveva
recuperato quella capacità, dice da Empoli. “Nei suoi momenti migliori –
le primarie del 2012 e poi soprattutto i primi mesi del governo Renzi e
le elezioni europee del 2014 – il Pd ha saputo intercettare la rabbia
degli scontenti, che è all’origine del successo di Grillo e degli altri
trumpisti”. Renzi ha adottato, fin dall’inizio, “alcuni atteggiamenti
tipici dello stile populista”, restando però “l’unico leader moderato a
essere riuscito – almeno per una fase – a intercettare l’energia della
rabbia popolare per portarla nella direzione di un programma di riforme e
di apertura… Certo, col passare del tempo la capacità del governo Renzi
di dare uno sbocco politico alla rabbia è andata riducendosi, fino alla
pesante sconfitta del referendum”.
Finora,
ci sono stati tre tentativi di risposta al grillismo. “La tentazione
giacobina”; “la tentazione elitaria”; “la tentazione dorotea”. La prima
consiste nell’inseguire i grillini sul loro terreno, diventando più
populisti, più antipolitici e più giacobini di loro, adottando un frame
che quindi darà solo vantaggi agli inseguiti e non agli inseguitori. La
seconda consiste nell’attribuire il successo del M5s all’ignoranza e
alla manipolazione, come se il Movimento prendesse milioni di voti per
qualche centinaio di troll su Twitter e Facebook. La terza consiste
“nell’asserragliarsi nel bunker del sistema, in un grande revival
nostalgico della Prima Repubblica”. Le tre tentazioni, portate alle
estreme conseguenze, dice da Empoli, sono destinate a fallire. Così come
è destinata a fallire la sola opera di denuncia costante delle
contraddizioni, degli abusi e delle violazioni dei principi democratici
del M5s. All’origine del successo del populismo grillino c’è una
formidabile capacità di attrazione della rabbia che un tempo, come ha
rilevato il filosofo Peter Sloterdijk, era propria dei partiti di
sinistra, che “sono stati per tutto il Novecento i collettori
privilegiati della rabbia popolare”. Recentemente, il Pd aveva
recuperato quella capacità, dice da Empoli. “Nei suoi momenti migliori –
le primarie del 2012 e poi soprattutto i primi mesi del governo Renzi e
le elezioni europee del 2014 – il Pd ha saputo intercettare la rabbia
degli scontenti, che è all’origine del successo di Grillo e degli altri
trumpisti”. Renzi ha adottato, fin dall’inizio, “alcuni atteggiamenti
tipici dello stile populista”, restando però “l’unico leader moderato a
essere riuscito – almeno per una fase – a intercettare l’energia della
rabbia popolare per portarla nella direzione di un programma di riforme e
di apertura… Certo, col passare del tempo la capacità del governo Renzi
di dare uno sbocco politico alla rabbia è andata riducendosi, fino alla
pesante sconfitta del referendum”.