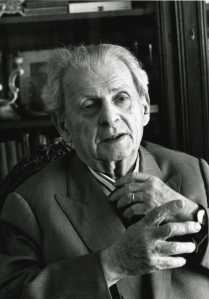Ci sono sempre su Internet delle belle cose che passano quasi
inosservate. Cercavo oggi qualche estratto dalla biografia di Ingrid
Bergman. Non sono riuscito a trovarlo. Mi sono imbattuto invece in una
voce di enciclopedia che aveva per oggetto l’attrice svedese. Mi è
sembrata un piccolo gioiello. Conteneva il percorso biografico
dell’attrice. si pronunciava va via via sul valore delle sue apparizioni
cinematografiche e teatrali: ne veniva fuori un ritratto della persona,
di ciò che era stata e un quadro ben congegnato di ciò che la Bergman
medesima aveva significato nella storia del cinema. Spesso anche tra gli studiosi si pensa che la verità stia nei
documenti che giacciono negli archivi, nei diari inediti, nella
corrispondenza, in foto mai rese pubbliche. Eppure che cosa è stata
Ingrid Bergman per gli spettatori dei tanti film da lei interpretati non
è propriamente un segreto. Ore e ore di cinema lo lasciano
intuire senza tante difficoltà. Ci potranno poi essere e ci sono gli
approfondimenti critici. Ciò non toglie che la verità elementare dei fatti è perfettamente
accessibile. Si tratta di guardare con attenzione, annotare con
scrupolo e riferire. E’ quanto ha fatto Monica Trecca nel testo che
segue.
Monica Trecca
BERGMAN, Ingrid
Enciclopedia del cinema, 2003
Attrice cinematografica e teatrale svedese, nata a Stoccolma il 29
agosto 1915 e morta a Londra nel 1982 nello stesso giorno della sua
nascita. A partire dagli anni Quaranta si era imposta negli Stati Uniti
come star profondamente amata, acclamata in tutto il mondo come una
delle più raffinate interpreti della storia del cinema, in parti che
sono patrimonio dell’immaginario e che le valsero sette nominations e
tre premi Oscar oltre a numerosi altri prestigiosi riconoscimenti anche
per i suoi ruoli teatrali. Dotata di una luminosa bellezza e di una
grande sensibilità, fu sempre pronta a rimettersi in discussione,
incapace di rimanere prigioniera di ruoli circoscritti e prefissati
nella vita privata come in quella professionale.
La sua infanzia era stata funestata da lutti dolorosi: a soli due
anni aveva perso la madre (la tedesca Frieda Adler), a dodici il padre
(un fotografo che le aveva insegnato il gusto di posare), quindi la zia
che l’aveva allevata. Cresciuta nella famiglia dello zio paterno, nel
1933 entrò a far parte della scuola del Dramatiska Teater di Stoccolma.
Ottenne quindi una breve parte in un film di Gustaf Molander e in poco
tempo si affermò come giovane promessa del cinema svedese. Dopo essersi
sposata nel 1937 con un medico, Petter Aron Lindström, e aver girato un
film in Germania, nel 1939 giunse negli Stati Uniti chiamata dal
produttore David O. Selznick, colpito dalla sua interpretazione in
Intermezzo
(1936), ancora di Molander. Ottenuto un personale successo con il
remake del film svedese, diretto in quello stesso anno da Gregory
Ratoff, e dopo due film non memorabili, la B. decise di imprimere una
prima svolta alla sua carriera per sfuggire alla prigione hollywoodiana
costituita dai ruoli rassicuranti della dolce eroina romantica dal
sorriso radioso. Scelta per interpretare la fidanzata remissiva nel
nuovo film di Victor Fleming
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1941;
Il dottor Jekyll e Mr Hyde),
al fianco di Spencer Tracy, s’impose per ottenere il ruolo di Ivy, la
spregiudicata cameriera dapprima salvata da Jekyll e poi tormentata da
Hyde in una claustrofobica prigione di paura. Furono quelli anni segnati
da clamorosi successi (proprio in corrispondenza con il ritiro dalle
scene dell’altra grande attrice svedese Greta Garbo) che ne fecero la
diva più ammirata dal pubblico, quasi venerata come modello di
perfezione, madre e moglie esemplare. A consacrare la sua affermazione
fu
Casablanca, diretto nel 1942 da Michael Curtiz e destinato
nel tempo a divenire il film culto per eccellenza, che la vide accanto a
Humprey Bogart e nel quale le incertezze sul set circa l’andamento
della storia e il finale sembrano sublimarsi nell’interpretazione della
B., tormentata fino all’ultimo tra la scelta d’amore e quella del
dovere. Egualmente intenso fu il pathos recitativo che seppe esprimere
in
Gaslight (1944; Angoscia) di George Cukor, interpretando una
donna condotta sull’orlo della pazzia dal marito (Charles Boyer), ruolo
per il quale ottenne il suo primo Oscar nel 1945. Ma anche i film meno
riusciti come
For whom the bell tolls (
Per chi suona la campana)
diretto nel 1943 da Sam Wood, patinata versione del romanzo di E.
Hemingway, che aveva indicato proprio in Ingrid l’interprete ideale
della sua Maria, e il successivo
Saratoga trunk (1945;
Saratoga),
pastiche romantico sempre diretto da Wood e ancora accanto a Gary
Cooper, le procurarono comunque un enorme successo di pubblico e
l’apprezzamento dei critici. Fu però Alfred Hitchcock, conquistato dalla
sensualità apparentemente mascherata di freddezza della B., a
comprenderne più profondamente la complessità di donna e di artista.
Così dapprima riuscì a modellare sulla sua severità affascinante il
personaggio della razionale psicoanalista che si abbandona all’amore in
Spellbound (1945;
Io ti salverò). Quindi le offrì di animare di profonda umanità il ruolo, costruito per lei, di Alicia Huberman protagonista di
Notorious (1946;
Notorious ‒ L’amante perduta).
In quella parte l’attrice seppe esprimere tutta la sua personale
inquietudine, riuscendo a far affiorare, grazie anche all’intesa con il
partner Cary Grant, la ricchezza di emozioni che attraversano la storia
d’amore al centro di una cupa vicenda di spionaggio venata di ambiguità:
bisogno di fiducia, dolorosa diffidenza, desiderio di riscatto.
Successivamente, malgrado la gioia di portare a teatro il suo
personaggio preferito, Giovanna d’Arco, interpretando il dramma di
Maxwell Anderson, sia
Arch of Triumph (1948;
Arco di Trionfo) di Lewis Milestone, sia la stessa riduzione cinematografica del testo di Anderson per la regia di Fleming (
Joan of Arc, 1948,
Giovanna d’Arco: ridondante epopea medioevale in cui a venire santificata era la diva), e persino
Under Capricorn (1949;
Sotto il Capricorno o
Il peccato di Lady Considine),
girato in Inghilterra con la regia dell’amico Hitchcock, che volle
valorizzare l’intensità della sua interpretazione con lunghi e insistiti
piani-sequenza, la lasciarono insoddisfatta. Professionista rigorosa,
profondamente innamorata del suo lavoro, sentiva la necessità di
misurarsi con esperienze artistiche più stimolanti. Colpita dalla
visione di Roma città aperta e Paisà di Roberto Rossellini, la cui
poetica avvertiva così lontana dagli stereotipi hollywoodiani, l’attrice
scrisse al regista italiano desiderosa di lavorare con lui. I film che a
seguito di ciò interpretò in Italia appartengono a un mondo
immaginativo e artistico completamente diverso da tutto ciò che la B.
aveva realizzato sin lì, e il drammatico impatto tra la straniera
protagonista di
Stromboli ‒ Terra di Dio (1950) e l’aspra terra di Sicilia ne è quasi un metaforico manifesto. L’attrice conferì quindi intenso spessore alla Irene di
Europa ’51
(1952), singolare attualizzazione al femminile della figura di San
Francesco, tratteggiata sul limite tra pazzia e santità; mentre in
Viaggio in Italia
(1954) anticipò con rarefatta sensibilità futuri ritratti di donne
prigioniere dell’angoscia dell’esistere, suscitando l’entusiasmo dei
critici dei “Cahiers du cinéma”. Sempre per la regia di Rossellini, la
B. era inoltre apparsa nel solare episodio
Ingrid Bergman di
Siamo donne
(1953), ricco di humour, che la vede nei panni di sé stessa alla caccia
di una gallina, e in La paura (1954), girato a Monaco di Baviera,
disegnò invece una figura femminile estremamente moderna che però
all’epoca non venne compresa. Fu ancora una splendida Giovanna d’Arco
nell’oratorio
Giovanna d’Arco al rogo di P. Claudel e A.
Honegger, portato in tournée in numerose città d’Italia e d’Europa e da
cui Rossellini trasse un film (1954) con il medesimo titolo, capolavoro
di cinema sul teatro. Ma il sodalizio artistico e sentimentale tra
l’attrice e il regista (che si erano sposati per procura in Messico nel
1950) aveva suscitato un enorme scandalo soprattutto negli Stati Uniti
ove era stato vissuto come il tradimento di un’immagine, provocando un
vero ostracismo morale e violente stroncature del lavoro dell’attrice e
del regista. Esauritosi ormai anche il rapporto tra i due (il matrimonio
verrà annullato nel 1958 e l’attrice si risposerà con l’impresario
teatrale svedese Lars Schmidt), la B. tornò a recitare con altri
registi, e prima Jean Renoir con
Eléna et les hommes (Eliana e gli uomini) e quindi Anatole Litvak con
Anastasia,
entrambi del 1956, la restituirono al pubblico e alla critica in ruoli
assai vicini a quelli che l’avevano resa famosa a Hollywood. In
particolare, il personaggio della presunta ultimogenita di Nicola II le
valse il secondo Oscar (1957) che segnò la riconciliazione tra gli Stati
Uniti e la diva ritrovata. Seguì la commedia sofisticata Indiscreet
(1958; Indiscreto) di Stanley Donen in cui la B. interpreta un’attrice
di successo, sorta di suo sorridente doppio. I film successivi non le
offrirono in quegli anni ruoli di grande spessore, mentre ottenne
soddisfazioni in opere teatrali di successo: da
Edda Gabler di H. Ibsen, recitata in francese, a
More stately mansions di E. O’Neill, a
The constant wife di W.S. Maugham. Per il cinema fu invece la missionaria laica di
The inn of the sixth happiness (1958;
La locanda della sesta felicità) di Mark Robson; la malinconica protagonista di
Goodbye again (1961;
Le piace Brahms?) ancora di Litvak; l’interprete dell’ultimo episodio di
The yellow Rolls-Royce (1964;
Una Rolls-Royce gialla)
di Anthony Asquith e di uno degli episodi di Stimulantia (1967) diretto
dal regista che l’aveva lanciata, Molander. E ancora l’efficiente e
apparentemente glaciale infermiera della commedia
Cactus flower (1969;
Fiore di cactus) di Gene Saks, che segnò il suo ritorno a Hollywood. Con la breve eppure perfetta interpretazione della missionaria svedese in
Murder on the Orient-Express (1974;
Assassinio sull’Orient-Express)
di Sidney Lumet, ripresa in un unico piano-sequenza, si aggiudicò il
terzo Oscar nel 1975. L’anno successivo accettò di prendere parte ad
A matter of time (
Nina),
ultimo film diretto da Vincente Minnelli, dolente e malinconica
riflessione sulla fama e sulla paura della solitudine e del declino. Nel
1978 la B. offrì una delle sue più toccanti prove interpretando, per la
regia di Ingmar Bergman, una grande pianista che al successo ha
sacrificato il rapporto con i figli in
Höstsonaten (
Sinfonia d’autunno),
ruolo nel quale seppe dare tanto di sé, del dubbio doloroso che l’aveva
sempre tormentata di aver trascurato soprattutto la figlia Pia, avuta
dal primo marito (altri tre erano nati dal legame con Rossellini). Anche
l’ultimo suo ritratto di donna, protagonista di uno sceneggiato per la
televisione, la bruna Golda Meir, dai tratti marcati, fisicamente tanto
lontana da lei, così alta e chiara, fu un’ennesima prova di bravura
nella quale l’attrice, ormai molto malata, seppe trasfondere la
comprensione per questo personaggio forte, dalle scelte dure e
difficili. La morte sopraggiunse infatti solo pochi mesi più tardi, al
termine di una lunga e coraggiosa lotta contro la malattia.In
precedenza, nel 1980, aveva pubblicato l’autobiografia, Ingrid Bergman,
my story, alla cui stesura aveva collaborato lo scrittore A. Burgess.
Bibliografia
J.H. Steele,
Ingrid Bergman, an intimate portrait, New York 1959.
C.F. Brown,
Ingrid Bergman, New York 1973 (trad. it. Milano 1981).
E. Schaake,
Ingrid Bergman: ihr Leben, München 1980.
L.J. Quirk,
The complete films of Ingrid Bergman, New York 1989.
D. Spoto,
Notorious: the life of Ingrid Bergman, New York 1997 (trad. it. Torino 2000).
http://www.film.it/film/foto/dettaglio/art/ingrid-bergman-la-regina-di-cannes-42846/